Nel cuore della giungla birmana, tra pagode in rovina e piogge torrenziali, si gioca una guerra silenziosa che l’Occidente guarda con il consueto sguardo distratto, quello riservato alle guerre che non turbano il prezzo del petrolio. Le bombe che cadono su Mindat o Loikaw non portano il marchio esplicito del Cremlino o di Zhongnanhai, ma il metallo esploso conosce la via delle alleanze. Sono russe e cinesi, quelle bombe. Nella loro traiettoria c’è una firma silenziosa.
Lì sotto, tra i resti di monasteri e scuole, combattono i rivoluzionari democratici, giovani e contadini, monaci e insegnanti, che un giorno hanno detto no al golpe del 2021 e che da allora vivono braccati come animali mitologici. Il mondo li chiama PDF – People’s Defense Forces – ma sono solo uomini e donne che non hanno voluto cedere alla paura. Chi li sostiene? Nessuno, davvero. Al massimo qualche editoriale distratto, una risoluzione senza denti, qualche fondo ONG. L’Oriente multipolare – di cui molti in Occidente si riempiono la bocca – guarda e fornisce armi al boia.
Ci piace parlare di equilibrio globale, di tramonto dell’egemonia americana, di nuovi blocchi. Ma le categorie del potere non assolvono i crimini. L’idea che ogni imperialismo sia speculare e quindi tutto sia relativo è la maschera preferita dei complici. C’è ancora, ostinatamente, un confine tra giusto e sbagliato. Non assoluto, non metafisico, ma concreto, come il sangue versato da chi resiste, come il silenzio vile di chi commercia con i carnefici. La civiltà, forse, non è altro che la capacità di dire “no” anche quando conviene dire “sì”. Anche quando il mondo è stanco, e il cinismo pare l’unica religione rimasta.
Il Myanmar è un laboratorio di quello che accade quando il mondo smette di guardare. Non solo con gli occhi, ma con la coscienza. È lì che si realizza il sogno oscuro di ogni regime: l’impunità in cambio della distanza. Nel linguaggio delle cancellerie, questa si chiama “non ingerenza negli affari interni”. Una formula elegante per dire: possiamo lasciare che si trucidi un popolo, purché il massacro sia geograficamente remoto e diplomaticamente utile. La Cina ha bisogno di stabilità per i suoi oleodotti. La Russia, di vendere armi e droni. L’India, di contenere l’influenza cinese. L’Occidente, di non aprire un nuovo dossier. Così, la tragedia si compone: ogni potenza partecipa con un silenzio, un tornaconto, un cinismo.
Nel frattempo, le donne delle etnie Chin o Karen combattono armate di fucili arrugginiti. Non lo fanno per ideologia, ma per istinto di giustizia. Hanno letto Orwell – che in Birmania fu giovane poliziotto coloniale – e sanno che il mondo si divide ancora tra chi abusa e chi resiste. Non sempre si può parlare di Bene e Male. Ma ci sono momenti in cui il Male ha un indirizzo preciso, un’uniforme, un elicottero da cui sganciare il fuoco. In Occidente ci si emoziona per Zelensky, si sventolano bandiere, si moltiplicano analisi e fondi. Ma la democrazia, quando è nuda, quando non serve a nessuno, quando non appartiene a una “civiltà”, non suscita la stessa compassione. Un contadino Karen non è un ucraino in giacca e cravatta. Non può andare a Davos, non sa parlare inglese. E quindi la sua libertà vale meno. Forse è qui che la maschera multipolare si dissolve: nel valore che attribuiamo a una vita. Nelle differenze di peso che applichiamo al dolore. In quel modo asimmetrico in cui ascoltiamo le grida del mondo. E allora viene da chiedersi: cos’è davvero l’Oriente? È solo una direzione, un mercato, una promessa di ordine alternativo? O è anche la rimozione delle contraddizioni più feroci, il sacrificio dell’individuo all’altare dell’armonia?
L’Occidente non è innocente. Ha colonizzato, bombardato, imposto. Ma ha anche prodotto l’idea che il potere possa essere messo in discussione. Che la coscienza possa ribellarsi allo Stato. Che una persona, sola, abbia diritto a dire “no”, e che quel “no” abbia valore. È un’idea imperfetta, spesso tradita. Ma è un seme che, altrove, ancora non ha attecchito. Ecco perché non possiamo solo rallegrarci della fine dell’egemonia americana, o salutare il sorgere dell’Asia come se fosse un destino salvifico. Perché non tutti gli imperi sono uguali, e non tutte le civiltà sono disposte a tollerare la disobbedienza.
In Myanmar, oggi, si combatte anche per questo: per il diritto di non inginocchiarsi, di scegliere, di respirare senza chiedere il permesso. E noi, nel nostro silenzio pieno di analisi e teorie, rischiamo di essere gli spettatori consenzienti di un’altra tragedia che non ci tocca abbastanza.
27 aprile

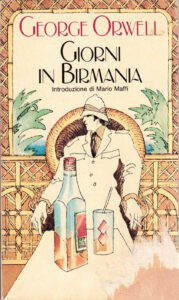
E’ possibile acquistare “Giorni in Birmania” nella vostra libreria di quartiere nelle recenti edizioni di Mondadori.
